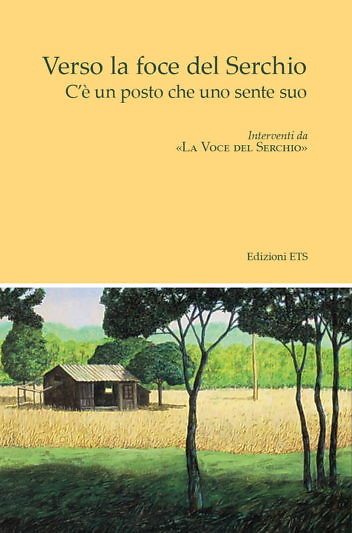 Raccontare ed esprimere sensazioni con la fotografia
Raccontare ed esprimere sensazioni con la fotografia
In questi ultimi anni vi è stato un proliferare di libri scritti da persone che di professione non fanno gli scrittori, dedicati ai luoghi sentiti come propri, i luoghi, per usare il linguaggio di Franco La Cecla dell’abitare, inteso come una sorta di sentirsi a casa propria in un certo spazio geografico, i luoghi contrapposti ai nonluoghi, come li ha chiamati un altro antropologo, Marc Augé.
Tale tematica è stata affrontata recentemente, per luoghi del territorio pisano, anche sul giornale “La Voce del Serchio” mediante la scrittura di una serie di testi che poi sono stati raccolti in un volumetto “Verso la foce del Serchio. C’è un posto che uno sente suo”, edizioni ETS, ma anche in altri testi usciti in edizioni limitate per volontà dei loro autori innamorati dei luoghi in cui sono nati e cresciuti come “Arselle. Al fortino di Boccadarno” di Fabiano Corsini, edizioni Felici, e “Molina mon amour. Storie di un paese del Lungomonte pisano” di Gabriele Santoni, Edizioni ETS.
In tutti questi testi, attraverso la parola, la narrazione, i diversi autori hanno cercato di esprimere il loro legame affettivo con un determinato spazio geografico che in qualche modo, attraverso quei legami raccontati, descritti, esce dalla continuità spazio-temporale in cui viviamo e diventa un soggetto a sé stante strettamente legato al soggetto che racconta e talvolta ai soggetti che leggono o ascoltano. Molto probabilmente era il meccanismo con cui nel mondo della cultura orale si creava il senso dell’appartenenza, un meccanismo che è diventato più complesso con l’invenzione della scrittura e ancor più della stampa in quanto il soggetto destinatario è diventato sempre più un soggetto isolato.
La quasi totalità dei racconti individua nella memoria, nel ricordo, nel confronto con il passato un elemento per riconoscere come proprio un determinato luogo. In questo senso questi testi diventano anche racconti, narrazioni. E allora ci si può chiedere se è possibile fare la stessa cosa attraverso la fotografia e quindi con un linguaggio che funziona in modo profondamente diverso da quello verbale, se anche con la fotografia è possibile cercare di ricostruire un legame con la propria identità, un legame di appartenenza, ben diverso dalla fotografia usata per testimoniare una presenza in un luogo come fa il turista di massa.
Con la fotografia non si possono fare le stesse cose che si fanno con la parola. In fondo anche fare una fotografia è ritagliare, delimitare uno spazio per trasformarlo in un’altra cosa, in un soggetto, nel soggetto della fotografia. Certo fare una fotografia non è solo questo perché per fotografare occorre un altro elemento fondamentale: il tempo. Ma il tempo della fotografia è una cosa ben diversa dal tempo della narrazione. La fotografia è un’interruzione della continuità non solo spaziale ma anche temporale in quanto la fotografia è il prodotto di una specie di lotta contro il tempo, è il tentativo di arrestare il flusso del tempo. Proprio perché fotografare è interrompere la continuità temporale, diventa difficile esprimere mediante il linguaggio fotografico il momento della durata, l’intervallo di tempo tra un fatto e un altro che è l’elemento fondamentale della narrazione, del racconto elemento che invece è centrale nei testi apparsi su “La Voce del Serchio”. Certo la fotografia è o può esser un supporto della memoria e in tal modo è stata utilizzata nei due testi Arselle e Molina mon amour; ma in questo caso le fotografie utilizazte sono le vecchie fotografie, le fotografie di luoghi o persone che spesso non ci sono più o sono profondamente mutati. La fotografia è in questo caso utilizzabile come deceleratore dell’azione demolitrice del tempo e come supporto evocativo del ricordo, della memoria. Ma la questione sollevata dal libretto è un altra. L’uso della fotografia in analogia con il racconto in fuzione del riconoscimento dell’appartenenza ad un luogo. Fotografie quindi da scattare.
Possiamo cercare di affrontare il problema analizzando come alcuni fotografi hanno costruito la relazione visiva con i luoghi che sono diventati soggetti delle loro fotografie. Si può ad esempio cercare di capire, partendo dalle riflessioni contenute in un recente saggio di Roberta Valtorta contenuto in “Luogo e identità nella fotografia italiana contemporanea” Einaudi e in un altro libro di Antonella Russo “Storia culturale della fotografia italiana” sempre dell’Einaudi come alcuni fotografi che hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia della fotografia italiana hanno usato la fotografia per parlare dei luoghi in modo che fosse anche coinvolto una forma di relazione affettiva con quel soggetto.
Non parlo di paesaggio perché il termine rimanda ad un concetto che non mi piace molto, quello di genere. Volutamente non parlo di generi per due motivi. Il primo che parlare di generi rispetto alla tematica dei luoghi è limitativo in quanto subito viene depotenziato l’aspetto della relazione emotiva. Il secondo motivo e che è limitativo in generale pensare alla fotografie attraverso i generi. Qualche tempo fa Carlo Delli ha accennato a questo problema dei generi dicendo che secondo lui la classificazione, perché quando si parla di generi si parla di classificazione, è uno strumento importante per la costruzione della conoscenza e quindi anche della conoscenza della fotografia. Ha anche citato la biologia come esempio. Io credo che la questione della classificazione dei generi sia solo una modalità per costruire la conoscenza, una modalità che non sempre dà risultati positivi. Ad esempio l’applicazione del modello classificatorio agli archivi ha prodotto dei danni enormi nel momento in cui si sono messi insieme i documenti per tipologia, i contratti con i contratti, gli statuti con gli statuti, perdendo il legame storico che ciascun documento ha con gli altri rispetto, ad esempio, al soggetto che li ha prodotti. La classificazione ha distrutto le capacità conoscitive di una quantità enorme di documenti tanto che si sono dovuti riorganizzare molti archivi per ricostruire questa capacità di conoscenza ricollocando i documenti sulla base della loro produzione nel tempo. La stessa cosa accade, secondo me, con la fotografia che ha al suo centro non tanto il genere quanto l’unità tematica, l’idea, ciò che si vuol esprimere o comunicare attraverso essa. Quando ad esempio si parla della fotografia di Ansel Adams o di Basilico come fotografia di paesaggio è estremamente riduttivo pensare ad un genere. Dietro queste fotografie ci sta una filosofia del rapporto tra immagine e realtà, un’idea della funzione dell’immagine nella costruzione del rapporto con la realtà e nella costruzione di una cultura in cui l’immagine ha un determinato posto.
Per tornare alla questione iniziale, vorrei porre l’attenzione sulla questione dell’individuazione mediante una certa operazione condotta attraveso un linguaggio specifico, sia esso quello verbale che quello fotografico, di uno spazio delimitato, definito che si può connotare con il termine luogo, per riprendere il concetto proposto all’inizio degli anni ‘90 da Marc Augè, il concetto di nonluogo. Marc Augè propose l’introduzione del concetto di non luogo come neologismo da utilizzare per riferirsi a una serie di spazi presenti nella nostra vita quotidiana che hanno non solo determinate caratteristiche fisiche specifiche ma anche caratteristiche che riguardano le relazioni tra le persone che in quello spazio si trovano a svolgere determinate funzioni, a vivere una parte della loro vita. Marc Augé definisce i nonluoghi, in contrapposizione ai luoghi antropologici, quegli spazi che hanno la prerogativa di non essere identitari, relazionali e storici. Fanno parte dei nonluoghi secondo Augé alcuni grandi vie di comunicazione costruite per rendere più veloce la circolazione delle merci (autostrade, svincoli e aeroporti ), alcuni mezzi di trasporto come treni a grande velocità, aerei, navi da crociera, i grandi centri commerciali, le sale d’aspetto delle grandi stazioni eccetera. Spazi simili in tutte le parti del mondo in cui milioni di soggetti si incontrano senza entrare in relazione, spazi che ricordano un film di parecchi anni fa tratto da un romanzo che aveva lo stesso titolo, Turista per caso, film in cui il protagonista viaggiava per motivi di lavoro cercando sempre di ritrovare qualsiasi parte del mondo gli stessi ambienti, gli stessi cibi, le stesse abitudini, una sorta di viaggio senza cambiamento, senza spaesamento, senza la possibilità di perdersi e di ritrovarsi, esperienze costitutive fondamentali dell’esistenza e della capacità di narrare quindi.
Potremmo dire che i nonluoghi sono spazi in cui si vive solo il presente, il transito e il passaggio, dove si vive in mezzo agli altri una sorta di individualismo condiviso, uno stare insieme senza comunità. I nonluoghi sono i gli spazi dove si transita, ma non dove si vive né dove si abita, dove si costruisce esperienza e dove si dà senso a tale esperienza.
Il tema proposto, e molti dei testi presenti nel volumetto lo confermano, sembra un tema che chiede di tornare a scoprire i luoghi in contrapposizione ai non luoghi che minacciano gli spazi carichi di memoria, di relazioni vissute, a farli rivivere mettendo in risalto proprio gli aspetti identitari, della memoria, delle relazioni tra le persone.
Ad esempio Sergio Costanzo nel suo testo “Perché vale la pena viverci bene” parla del luogo in cui è cresciuto come elemento attraverso il quale costruire un senso di appartenenza che in qualche modo si confronti con il senso di appartenenza legato al vincolo sociale, a quello che lui chiama il richiamo del branco. Riconosce nelle caratteristiche specifiche del luogo in cui è cresciuto, il mare, i tramagli, le sciabiche, le reti da pulire, i monti d’asparagi, l’odore di ragia mista a muffa gli elementi di che hanno avuto un ruolo importante per la sua identità in quanto oggetti della comunità di appartenenza. Allo stesso modo i luoghi, gli elementi di specifici del paesaggio di questi luoghi, il mare, la spiaggia, il fiume ritornano nel testo di Bruno Baglini fondamenti principali dell’abitare in un luogo, in questo specifico luogo insieme agli altri tramite la condivisione delle esperienze e dei significati legati agli oggetti, al visivo, alle rappresentazioni visive comuni.
La lettura di questi testi fa emergere continuo alternarsi di immagini mentali di luoghi che suscitano ricordi, che richiamano a loro volta persone, relazioni, stati d’animo, cose. Alla domanda perché vale la pena vivere questi posti la risposta è quasi unanime. Perché sono i luoghi dove siamo cresciuti dove si è formata la nostra identità.
PAUL STRAND, CESARE ZAVATTINI: UN PAESE
Un tentativo di fare un’operazione simile utilizzando il linguaggio fotografico la ritroviamo in un testo della metà degli anni Cinquanta. Circa 60 anni fa uscì forse il primo libro fotografico italiano, “Un paese”, un libro prodotto a due mani e dedicato a un paese della bassa padana, Luzzara. Una mano era quella di Cesare Zavattini, sceneggiatore, giornalista, commediografo, scrittore, poeta e pittore italiano, uno dei maggiori esponenti del neorealismo cinematografico italiano, uno dei teorici del neorealismo, colui che aveva elaborato in quegli anni la cosiddetta “teoria del pedinamento” che consiste nell’idea che il compito del regista sia il pedinare la realtà, seguirla senza farsi vedere e cogliere la vita dell’uomo nella sua reale essenza. Per Zavattini “Un paese” rappresentava il proseguimento dell’estetica e dell’etica neorealista teorizzate in campo cinematografico grazie al mezzo fotografico e letterario. Luzzara era il paese di Zavattini. L’altra mano era quella di Strand, fotografo americano, uno dei padri della fotografia diretta, una fotografia basata sulla fotografia pura sottratta all’attrazione della pittura, una fotografia che si propone di riprodurre in maniera obiettiva la realtà senza l’ausilio di alcun artificio, una fotografia basata sul principio che qualunque cosa in grado di alterare la fotografia rende automaticamente meno puro lo scatto e, quindi, meno vero.
Sembrano due mani unite dagli stessi intenti anche se poi forse il risultato non è stato così coerente in quanto la fotografia di Strand poi si è rivelata ieratica, i soggetti sono diventati quasi monumenti e quindi in qualche modo separati dalla loro quotidianità. Comunque “Un paese” è un libro importante nella storia della fotografia italiana che mette in contatto modo diretto lo fotografia del nostro paese con quella americana che negli anni 30 aveva sviluppato un modo di fare fotografia completamente nuovo. Negli Stati Uniti negli anni Trenta si era formato il Gruppo f/64. Tra i fondatori del Gruppo f/64 c’era Ansel Adams con la sua passione per i paesaggi naturali, per i grandi parchi, per il paesaggio come natura selvaggia come era nella grande tradizione della pittura e della fotografia americana di paesaggio. Secondo Adams, la maestosità della natura reale non ha nulla da invidiare alle manipolazioni stilistiche proprie del pittorialismo e tale potenza espressiva può manifestarsi solo grazie ad una fotografia nitida, pura. F/64, appunto, è l’apertura minima di diaframma per ottenere il più alto valore di profondità di campo: la netta, assoluta nitidezza.
Sempre negli anni Trenta e sempre negli Stati Uniti si era affermata un’altra tendenza fotografica, quella documentaria che aveva visto in fotografi come Walker Evans e Dorothea Lange i maggiori esponenti, fotografi che documentarono per conto dell’FSA il disagio della popolazione rurale americana nel periodo della crisi economica del ’29 e del decennio successivo.
« Documentaria è la fotografia della polizia scattata sul posto di un delitto. Quello è un documento. Vedi bene che l’arte è senza utilità, mentre un documento ha un’utilità. Per questo l’arte non è mai un documento, ma può adottarne lo stile. È quello che faccio io.» (Walker Evans)
Strand proviene da questa clima culturale e aveva in mente da molti anni di fotografare un intero paese attraverso la fusione dei volti degli abitanti con i luoghi appartenenza che era il suo modo di intendere il ritratto. Zavattini a sua volta aveva aveva un progetto simile. In quegli anni Zavattini stava lavorando con Einaudi ha una serie di fascicoli dal nome “Italia mia”. Doveva essere una collana di libri fotografici accompagnati da didascalie e dedicati a illustrare la vita quotidiana degli italiani, cosa mangiavano, quanti soldi avevano in tasca e così via. Dall’incontro dei due nacque “Un paese”. Zavattini si occupò soprattutto di scrivere i testi sulla base delle testimonianze raccolte dai suoi compaesani. I testi raccolti da Zavattini costituiscono una sorta di antologia che illustra la realtà quotidiana di Luzzara negli anni 50. Il volume non fu accolto in modo benevolo dalla critica. Subito fu notato il distacco tra i testi di accento popolaresco e le immagini quasi etnografiche, dotate di una sorta di rigore monumentale, di solennità che era proprio delle fotografie di Strand (Franco Fortini – Enrico Falqui).
Certo “Un paese” è una cosa ben diversa dalla ricerca dei luoghi che si trova nel volumetto che sta alla base dei testi di cui ho parlato all’inizio. “Un paese” ha costituito per la storia la fotografia italiana, secondo Zannier, un punto di svolta perché ha introdotto una modalità di affrontare linguaggio fotografico che era assente nella cultura fotografica italiana, un modello che sarebbe stato ripreso più tardi. Però quello che mi sembra interessante è il modo con cui attraverso la fotografia si cerca di descrivere un luogo. L’intento è quello documentario ma il risultato io credo sia un’altra cosa perché nel momento in cui si sceglie di fotografare un luogo, così come si sceglie di descriverlo in un ambito come quello letterario o comunque artistico, narrarlo, si compie un’operazione che non è solo documentaria ma anche espressiva nel senso di coinvolgimento emotivo. Tutto il neorealismo ed anche la fotografia americana degli anni Trenta hanno alla loro base questa componente espressiva che si può tradurre nel tentativo di far uscire il quotidiano dall’anonimato, di dargli attraverso la fotografia o con la scrittura una dignità etica ed estetica.
Ghirri dopo circa trent’anni, verso la metà degli anni 80, parlando di “Un paese” disse che per lui era una sorta di commovente canto della terra che restituiva al territorio della bassa padana una dignità poetica. Una dignità poetica che in qualche modo riaffiora anche in alcuni testi su Vecchiano e la Val di Serchio attraverso i sentimenti, le sensazioni che gli autori di quei testi per i luoghi che sentono come propri.
Per quanto riguarda invece la possibilità di raccontare, è interessante il fatto che Luzzara sia stata il soggetto fotografico di almeno altri due libri, uno curato sempre da Zavattini con le fotografie Berengo Gardin uscito nei primi anni 70, l’altro uscito intorno al 2004 con le fotografie di Fabrizio Orsi e Marcello Grassi. Gli altri due testi hanno ripercorso l’itinerario a loro volta l’itinerario di ricerca del primo producendo fotografie sono diventate un punto di riferimento per l’analisi storica e socio antropologica di questo paese. Non ci sono più i volti dei contadini, la grande quantità di biciclette, le vecchie botteghe, ma supermercati, palestre, volti di stranieri e le prime tracce del superamento della fase dell’industrializzazione. Il susseguirsi di questi tre libri consente di dare una prima risposta alla domanda se è possibile esprimere sensazioni, stati d’animo, emozioni verso un luogo con la fotografia come si fa con la parola. La prima risposta è sì se non si pensa alla singola fotografia ma alla serie di fotografie legate tra loro da un vincolo di coerenza tematica. I testi usano la narrazione come elemento fondamentale della loro capacità espressiva e io non credo che la singola fotografia possa raccontare perché la fotografia, la singola fotografia è il prodotto di una specie di lotta contro il tempo, del tentativo di fermare il tempo che è esattamente il contrario di ciò che sta alla base della narrazione, della ricostruzione del succedersi delle vicende del tempo. Ma la serie di fotografie può diventare racconto. Inoltre la fotografia singola, senza didascalia, separata da altre fotografie, è una sorta di oggetto decontestualizzato, aleatorio. Quello che fa la fotografia credo sia ciò che viene chiamato evocazione, cioè fornire elementi attraverso il quale andare oltre ciò che si vede, suggerire che quello rappresentato è soltanto un frammento di una realtà che si sviluppa ben oltre i limiti stabiliti dai bordi della fotografia. Per raccontare credo sia necessario introdurre almeno un altro elemento, quello della serialità, del legame che si crea quando abbiamo di fronte una serie di fotografie unite da vincoli tematici e anche stilistici.
MARIO CRESCI: MARTINA FRANCA IMMAGINARIA
Per continuare a cercare trovare risposte alla domanda se è possibile rappresentare attraverso la fotografia il legame con un luogo possiamo prendere in considerazione un altro libro fotografico “Martina Franca immaginaria” di Mario Cresci. È un libro dei primi anni Ottanta. In queste fotografie l’elemento documentario è quasi assente. Prevale l’elemento espressivo grazie ad un linguaggio fotografico che si fonda sulla scelta di evidenziare alcuni aspetti fisici, il bianco delle case esaltato dalla scelta di stampe dove prevalgono i toni alti, la materia di cui sono fatti i muri che fungono da scenario invadente, spesso esteso su quasi tutta la fotografia, entro il quale, quasi di sfuggita, come ricordi fugaci, appaiono figure umane spesso sfocate o mosse, oggetti, porte. Il luogo diventa uno strumento per la rappresentazione di una dimensione espressiva, allusiva, finalizzata a creare una sorta di altro paese, appunto immaginato e nello stesso tempo prodotto attraverso le immagini fotografiche, quindi legate al reale ma utilizzate quasi per creare una realtà diversa, una sorta di paese immaginario, di finzione, di descrizione non del paese reale ma, attraverso le immagini, la costruzione di un altro paese che affianca quello reale grazie al paese reale. È un’operazione che avvicina la fotografia a ciò che fanno la letteratura e la pittura, cioè la creazione di altri mondi che però conservano con la realtà un legame forte, fino a diventare strumenti per guardare la realtà con un’altra prospettiva, strumenti che segnano il passaggio dal senso di realtà al senso del possibile, e il senso del possibile e uno strumento fondamentale per la sopravvivenza dell’essere umano. L’isolamento quindi di alcune caratteristiche, l’esaltazione di alcuni elementi che rivelano un legame particolare con il luogo (il colore, la luce, gli edifici, le persone e le loro attività) possono diventare strumenti per legare l’imamgine, il soggetto e il luogo.
MARIO GIACOMELLI
Per proseguire sul filone della fotografia dei luoghi come espressione di sensazioni, emozioni possiamo prendere in esame alcune foto di Mario Giacomelli, foto che appartengono a tre raccolte, “La buona terra”, “Metamorfosi della terra” e “Presa di coscienza della natura”, tutte fotografie delle colline marchigiane il luogo in cui Giacomelli è nato e vissuto.
LA BUONA TERRA
Giacomelli dice che con la serie la “Buona terra” ha voluto soprattutto raccontare il suo rapporto con il mondo contadino da cui Giacomelli proveniva, un mondo di cui Giacomelli era fiero. Le immagini di questa serie ritraggono la vita di una famiglia contadina e le attività dei componenti questa famiglia durante tutto l’anno. Con i suoi scatti Giacomelli ha voluto evocare i valori intorno ai quali, secondo lui, si svolgeva la vita della famiglia contadina, in particolare i valori della cooperazione, dell’aiuto reciproco tra le generazioni. Queste foto mi sembra evochino un senso di appartenenza che ha il suo centro nella tradizione e nella memoria ed è legata a un orizzonte locale circoscritto, perduto a causa del sopravvento della modernità, una sorta di nostalgia che può portare ad una costruzione illusoria, attraverso le immagini, di uno luogo che non è mai esistito o che è esistito ma con caratteristiche molto diverse, di un luogo solo immaginato ma in un senso diverso dall’immaginario di Cresci. Possiamo chiederci se per quei contadini la loro terra era veramente una buona terra. Mentre per Cresci si poteva parlare di un’immaginazione aperta, di un legame evocativo tra reale e immaginario, nel senso di un legame attraverso cui il reale viene in qualche modo visto attraverso l’immaginario, una finzione, per riprendere il linguaggio con cui il filosofo pisano Alfonso Iacono parla di di queste cose, in questo caso si può parlare di immaginazione chiusa, di inganno nel senso di far credere che esiste o è esistito qualcosa che invece non c’è o non c’è mai stato, un inganno che ha una funzione consolatoria ma nello stesso tempo anche una funzione di chiusura. È il rischio che si corre quando prende il sopravvento la nostalgia, il senso di una mancanza provocato da una memoria che in qualche modo tende a riempire e a sostituirsi al presente.
METAMORFOSI DELLA NATURA
In un’altra serie di fotografie di Giacomelli invece il paesaggio diventa un pretesto per una ricerca su alcuni aspetti della natura che cambiano a causa dell’intervento dell’uomo. In questa serie di fotografie che vanno sotto il nome di “Metamorfosi della terra” vengono raccontati mutamenti dei luoghi ripresi in momenti diversi nel corso degli anni narrando così attraverso la fotografia il loro cambiamento, il cambiamento della natura ad opera dell’uomo. Per esempio c’è una serie di foto che parte dalla immagine di una collina coltivata con una casa colonica, un terreno lavorato, un fienile, un pagliaio, una vigna. Nella foto successiva si può notare che non ci sono più alcune coltivazioni, indice di un cambiamento legato ad un diverso modo di lavorare la terra, di dedicarsi al lavoro dei campi. In un’altra foto successiva viene a sparire il pagliaio che può evocare l’eliminazione degli animali. Infine le ultime foto testimoniano l’abbandono della terra. Queste foto sono l’esempio di come la serialità può diventare narrazione della trasformazione dovuta all’azione del tempo, della durata e può diventare lo strumento per esprimere un altro importante sentimento, il rimpianto da un lato per un passato oramai perduto, dall’altro per uno spazio trasformato e quindi perso, causa di spaesamento. Ancora una volta centrale è il confronto tra passato e presente e la valutazione positiva del passato rispetto al presente, ma con una curvatura meno ingannevole, più documentaria rispetto alla serie de La Buona Terra.
PRESA DI COSCIENZA DELLA NATURA
In un’altra serie ancora di fotografie, “Presa di coscienza della natura”, foto prese dall’alto su un piccolo aereo o da una collina vicina, lo scopo è quello di comunicare il senso di verticalità del paesaggio delle Marche e nello stesso tempo l’artificialità di esso. Dal punto di vista fotografico il paesaggio diventa qualcosa di astratto, un insieme di segni e simboli di natura geometrica usati per creare effetti visivi. La realtà colta attraverso la macchina fotografica diventa uno strumento per costruire qualcos’altro diverso da essa, non semplice duplicato di essa:
La funzione espressiva della fotografia viene da queste immagini esaltata al massimo e viene messa in secondo piano, fino quasi a sparire, la funzione documentaria, ma questa cancellazione della funzione documentaria avviene proprio attraverso il documento stesso perché la fotografia è in ogni caso un documento. I semiologi hanno parlato di indice come elemento caratteristico dal punto di vista della significazione della fotografia, intendendo con indice segno che intrattiene un legame naturale, non frutto di convenzione, con l’oggetto designato, un legame che si basa su una contiguità, su un rapporto esistenziale con l’oggetto che significa. Nello stesso tempo la fotografia è anche icona, cioè segno che funziona attraverso la somiglianza senza avere un legame diretto con l’oggetto rappresentato. E questa natura duplice del segno fotografico che consente alla fotografia di funzionare in contesti con scopi molto diversi tra loro. Non esiste fotografia senza un legame naturale con l’oggetto e nello stesso tempo questo legame è il prodotto di scelte da parte di un soggetto che fotografa che in qualche modo rende più debole questo legame diretto senza però annullarlo. L’oscillazione tra la natura di indice e quella di icona è ciò che rende la fotografia sia un potente strumento di documentazione che ha comunque al suo interno una componente espressiva sia uno strumento capace di permettere una funzione espressiva conservando una natura documentaria. In queste fotografie non c’è la nostalgia, il passato che riempie il presente, ma l’indagine tesa a rivelare un altro possibile dei luoghi in cui abitiamo, in cui viviamo.
Giacomelli in suoi appunti degli anni ’90 dice di queste sue foto: “Paesaggio come atto di espressione totale dove sento lievitare la natura, il flusso traumatico del tempo. È la dimensione dello spazio ridotto a un’emozione unica. Un’estensione della mia esistenza dove il quotidiano, il ripetitivo, viene come filtrato dal fluente dell’immaginario. Io non ritraggo il paesaggio ma i segni, le memorie dell’esistenza di un “mio” paesaggio. Non voglio che sia subito identificato, preferisco che si pensi a certi segni, alle pieghe-rughe che l’uomo ha nelle sue mani. Un tempo questo pensare al contadino mi affascinava, perché sentivo il paesaggio come un grande reportage, puro, forte, tutto ancora da scoprire, da vivere. Mi sono poi accorto che fotografavo invece la mia interiorità, attraverso il paesaggio trovavo la mia anima. […] La terra ha dei segni, delle pieghe, che mi chiedevano di essere fotografati, così mi è sembrato. I segni erano disposti in maniera che l’anima potesse godere, segni interiori riflessi come azione creativa, stordimento e allo stesso tempo conoscenza, distruzione che costruisce. Terra come percorso di voglie, di sensibilità, di penetrazioni, di orgasmi, perché non si ripetano le cose visibili. Forse io non ho mai fotografato il paesaggio: lo ho solo amato”. Una ricerca quindi in cui le forme del paesaggio diventano i segni del rapporto affettivo con il luogo.
VIAGGIO IN ITALIA
Contemporaneamente all’uscita in Italia di “Un paese”, negli Stati Uniti la fotografia stava cambiando direzione. Robert Frank pubblica nel 1955 “Gli americani”. Frank elabora con questo libro un suo sguardo personale, capace di parlare della realtà in modo libero da dogmatismi estetici e da funzioni celebrative. “Gli americani” stravolge le regole del linguaggio fotografico e al contempo inserisce una sorta di operazione di disincanto, di liberazione dall’illusorio luogo comune del sogno americano inteso come fiducia nella capacità di sviluppo civile, economico, culturale del paese a partire da una situazione comunque superiore a quella delle altri parti del mondo. La fotografia diventa uno strumento meno compiacente, lontano dal sentimentalismo retorico e nostalgico.
Dal 1960 in poi l’America conobbe un’intensa rivalutazione del reportage, promossa da fotografi come Garry Winogrand e Lee Friedlander. Il loro lavoro si concentrò sulla cattura incondizionata di immagini provenienti dalla vita di città, senza alcun interesse per la minima preparazione o messa in posa dei soggetti.
« La fotografia è scoprire ciò che può accadere dentro una cornice. Quando metti quattro bordi attorno a dei fatti, cambi quei fatti. » (Garry Winogrand)
Cade da un lato il mito realista della fotografia come copia della realtà insieme alla funzione illusoria giocata dalla funzione estetica, dall’equilibrio formale che illude sulla natura del reale visto attraverso la fotografia, sul tentativo di elevare il mondo della miseria e della povertà, di darle una dignità culturale come aveva fatto il neorealismo italiano o la fotografia della FSA con i suoi ritratti monumentali.
Qualcosa di simile, ma più strettamente legato alla fotografia dei luoghi, accade in Italia qualche anno dopo. Intorno agli anni Ottanta esce un libro curato da Ghirri, con foto di una ventina di autori tra cui Cresci, Basilico, Jodice, Guido Guidi, Chiaramonte e lo stesso Ghirri: “Viaggio in Italia”
Come Frank, Winogrand e Freedlander, Ghirri propone un nuovo linguaggio fotografico anch’esso finalizzato a produrre una forma di disincanto, quella dell’idea romantica, idealistica, del bel paesaggio, del paesaggio italiano che era stato l’oggetto di altri viaggi, i viaggi di formazione dei giovani intellettuali europei come Goethe, Heine o Stendhal. Il contesto in cui esce questo libro è quello della consapevolezza che il paesaggio è profondamente cambiato come entità culturale e come entità fisica e al suo posto troviamo un’entità disomogenea. Con questa consapevolezza Ghirri comincia a fotografare non più i luoghi ricchi di memoria, i luoghi carichi di identità ma i luoghi comuni con un intento non di denuncia o di critica ma di ricostruzione della capacità di osservare, di scoprire, di ricostruire il rapporto con questo nuovo paesaggio e di riscoprire l’identità che questi luoghi possono ancora sopportare a dispetto della loro trasformazione.
Quello che ne viene fuori è un’immagine dei luoghi priva di retorica, antimonumentale e non celebrativa che ha al suo centro lo scopo di indagare il legame tra il luogo dell’identità senza l’interposizione degli stereotipi tipici di un’immagine creata su misura per i turisti, tipici soggetti ignari della presenza dei luoghi.
Non più la fotografia di denuncia né la fotografia di monumenti, spiagge, tramonti ma i luoghi in cui la persona comune vive. La fotografie comprese nel libro, secondo Roberta Valtorta, autrice di un recente saggio contenuto in un testo di cui è curatrice “Luogo e identità nella fotografia italiana contemporanea”, sembrano una sorta di saltellante abbecedario del paesaggio italiano presentato nei suoi elementi primari, fotografie semplici come in attesa di essere animate da accadimenti, fotografie lontane dal mito dell’istante decisivo di bressoniana memoria, fotografie cariche di riflessione.
CELATI VERSO LA FOCE
La fotografia di Ghirri è una fotografia apparentemente semplice, senza acrobazie legate a inquadrature ardite, a tecniche di composizione, fotografie dove prevale l’immagine frontale spesso presa leggermente dal basso verso l’alto, con colori tenui e attenuati anche talvolta dalla trasparenza, dalla neve, dalla nebbia, dal buio, trasformati dalla luce artificiale. Le sue fotografie sono il prodotto di una riflessione lenta che in qualche modo costituisce una sorta di sfida per la contemporaneità tesa alla dinamicità, alla ricerca del momento particolare, spesso isolato, esaltato. L’idea del fotografo modenese era quella di riuscire a costruire la nostra identità a partire non dai miti e quindi dalle rappresentazioni illusorie del paesaggio, ma dal quotidiano, da ciò che ci circonda, utilizzandolo però per animare l’immaginazione, come quando una foto diventa poco nitida a causa della nebbia, delle trasparenze. L’idea di Ghirri era quella di rendere abitabile ciò che ci circonda attraverso la fotografia usata non come documentazione del reale ma come strumento per andare oltre senza che questo oltre venga definito, descritto. Nella fotografia le cose ci appaiono come rappresentazione della realtà e non come copia, ci appaiono quindi nella loro apparenza e nella loro parzialità. La fotografia di Ghjirri, che non è cattura dell’istante, ma riflessione sulle cose, consente di percepire la loro natura in tutta la sua ricchezza e profondità, in tutta la vasta gamma di possibilità.
Le fotografie di Ghirri trovano una specie di realizzazione parallela in campo letterario grazie a uno scrittore che Ghirri avvicina proprio nel periodo in cui esce “Viaggio in Italia”: Gianni Celati. L’esperienza fotografica di Ghirri in qualche modo ispira una raccolta di racconti di Celati che è stata pubblicata con il titolo “Verso la foce”, un libretto di 140 pagine costituito da 4 racconti nati da altrettanti viaggi compiuti dall’autore fra il 1983 e il 1986 dal centro della pianura padana fino alla foce del Po nei paesi, lungo le strade, attraverso campi e distese di terra, su rive di canali e lagune, sugli argini Celati chiama questi racconti, racconti d’osservazione nell’ottica della vita quotidiana, con la consapevolezza che la capacità di osservazione è anche lo strumento che abbiamo a disposizione per uscire dall’apatia.
Un viaggiare che ha una natura tutta sua come l’andatura e i ritmi che l’autore si è dato. Una narrazione che utilizza una scrittura minimalistica, senza descrizioni letterarie, indugi di tipo estetico, sociologico o di denuncia. Celati vuol rendere il suo incontro con le cose che sono là, fuori di noi, così come sono perché solo tale rapporto può salvarci dalla solitudine in cui i nuovi spazi, i luoghi in cui siamo immersi ci riserva.
“Non aspettiamo niente ma niente ci aspetta, né un’astronave né un destino. Se adesso cominciasse a piovere ti bagneresti, se questa notte farà freddo la tua gola ne soffrirà, se torni indietro a piedi dovrai farti coraggio, se continui a vagare sarai sempre più sfatto. Ogni fenomeno è in sé sereno. Chiama le cose perché restino con te fino all’ultimo.” G. Celati “Verso la foce”
Celati vuole usare le parole per dare conto dell’adesione dello sguardo a quelle cose, senza la pretesa di offrire descrizioni, buone o accurate o penetranti per potenziare la capacità di osservare. Celati mutua questa idea da Ghirri che pensava fosse necessario liberarsi dalle vedute e dalle rappresentazioni codificate, predeterminate per scoprire che nei posti dove non c’è niente da vedere, in realtà c’è più da vedere, come capita nei posti apparentemente banali, o desolati. Celati dice di Ghirri che:
“…è riuscito a raccontare la fissità dello spazio vuoto, lo spazio che non si riesce a capire. Ha compiuto una radicale pulizia negli intenti o scopi dello sguardo. Finalmente ci ha fatto vedere che non spia un bottino da catturare, che non va a caccia di avventure eccezionali, ma scopre tutto ciò che può avere interesse perché fa parte dell’esistente. (…) Ci sono mondi di racconto in ogni punto dello spazio, apparenze che cambiano ad ogni apertura degli occhi, disorientamenti infiniti che richiedono sempre nuovi racconti: richiedono soprattutto un pensare – immaginare che non si paralizzi nel disprezzo di ciò che ci sta intorno”
IL PROFILO DELLE NUVOLE
Nel 1989, tre anni prima della sua morte improvvisa, esce un altro libro di Ghirri, “Il profilo delle nuvole”, una raccolta di fotografie che si muovono nell’ottica presente nei racconti di Celati, cioè nel tentativo di ricostruire la grammatica del guardare e del vedere alternativa a quella tradizionale. Ghirri usa la fotografia come strumento di indagine per scoprire le cose nei loro elementi primari, liberati dalla retorica, dagli stereotipi, dalle cristallizzazioni prodotti da una cultura paradossalmente chiamata “civiltà dell’immagine” che invece ha reso sempre più difficile guardare e vedere le cose del mondo. Sono fotografie che accolgono la realtà nella sua semplicità essenziale, fotografie ridotte al minimo dal punto di vista della ricchezza dei contenuti intesi in modo tradizionale. Niente di pittoresco, di magniloquente, di epico. Quella che viene fuori è un’altra possibilità di guardare le cose, una possibilità che si basa sul porre l’attenzione sugli aspetti che generalmente sono cancellati dalla memoria visiva, occultati allo sguardo dall’abitudine e dall’ordinarietà. Tali luoghi sono i bar, i distributori, i cancelli avvolti nella nebbia, i campi, le chiese isolate in mezzo alla campagna, gli edifici immersi la notte nella neve, le spiagge deserte. È un’indagine prodotta dalla voglia di scoprire il mondo che abbiamo intorno a noi che non vediamo. Sono fotografie guidate dal principio che “non ci sia nessun grande viaggio che sia più emozionante di una passeggiata per vedere i colori, gli oggetti del mondo che tutti i giorni ci circonda” (Ghirri).
SKYLINE
Ultimo libro preso in esame è un libro di Franco Fontana, “Skyline” uscito nel 1979 presso la casa editrice Punto e virgola, una casa editrice fondata proprio da Ghirri. Anzi “Skyline” è il primo libro pubblicato da questa casa editrice. È una sorta di paradosso perché l’idea di paesaggio di Ghirri è lontanissima da quella di Fontana e il primo libro della casa editrice di Ghirri contiene proprio fotografie di Franco Fontana. In queste foto sparisce quasi la connotazione geografica del luogo. Il paesaggio diventa quasi un pretesto per la costruzione dell’immagine astratta in cui prevalgono le forme e colori. In Skyline non troviamo la raffigurazione di luoghi con una propria identità. Sono fotografie che partendo da una realtà percepibile cercano di ridurre tale realtà all’essenziale costituito per Fontana dalle forme e dai colori. Assistiamo quasi ad una scomposizione della complessità di ciò che vediamo, una sorta di destrutturazione in cui però gli elementi della realtà rimangono tali perché è una destrutturazione non distruttiva, che mantiene intatto il principio di indicalità della fotografia, esaltando però nello stesso tempo la natura iconica di essa. Le fotografie a colori di Fontana richiamano in qualche modo la fotografia in bianco e nero di Giacomelli. Quello di Fontana è un’interpretazione estremamente soggettiva del paesaggio e quindi dello spazio che però consente di compiere delle operazioni che possono essere collegate all’idea dell’abitare. Sono operazioni che ad esempio compie nel libretto “Verso la foce del Serchio” Beatrice Gherardi quando parla del suo rapporto con i luoghi che vive come mediato dai cinque sensi che consentono una scomposizione della complessità percettiva del luogo, una modalità che le consente di approfondirne la conoscenza.
Per concludere vorrei ritornare al tema iniziale che partiva dal presupposto che in qualche modo nel libretto “Verso la foce del Serchio” ci sia il tentativo di recuperare l’idea di un luogo come elemento fondamentale per l’identità e come spazio per l’abitare inteso come costruzione di legami con le persone, gli oggetti, lo spazio in cui viviamo, tracciando così un confine netto tra ciò che è un luogo ciò che non è un luogo. C’è da dire che raramente luoghi e non luoghi esistono in “forma pura”. Molto probabilmente stiamo vivendo in una fase di transizione che ancora non riusciamo a percepire nei suoi elementi di fondamentali. Ad esempio i centri commerciali. Per le generazioni di coloro che non sono più giovanissimi tali centri sono senza dubbio nonluoghi. Tuttavia la loro collocazione tra i nonluoghi è stata oggetto di critiche soprattutto da parte di alcuni sociologi che hanno messo in primo piano la natura relativa del concetto di nonluogo: una ricerca effettuata in Italia su un vasto campione di studenti delle scuole superiori (Lazzari & Jacono, 2010) ha mostrato come i centri commerciali siano uno dei punti di ritrovo più importanti per gli adolescenti. Probabilmente i “nativi digitali ” sono nativi anche rispetto ai centri commerciali, nel senso che non li percepiscono come una cosa altra da sé: i ragazzi sentono il centro commerciale come un luogo vero e proprio, di frequentazione non casuale e non orientata soltanto all’acquisto, dove si può esprimere la socialità, incontrare gli amici e praticare con loro attività interessanti. Ghirri aveva forse percepito questa complessità e la necessità di andare oltre queste dicotomie. Un luogo diventa tale solo se oltre c’è altro, se in qualche modo è delimitato e ciò che delimita è una frontiera che può essere attraversata, dove l’attraversamento è uno spostamento verso l’ignoto, verso il fascino dell’infinito. Un’esperienza comune e per cui i luoghi vengono percepiti come tali solo dopo che sono stati abbandonati, dopo che sono stati vissuti come limite, come chiusura. Forse in ambito visivo possiamo dire che i luoghi possono essere visti solo dopo che sono stati fotografati. Il che non vuol dire che ci si deve rassegnare alla trasformazione distruttiva dell’ambiente, ma anzi che è necessario dare dignità anche agli aspetti più banali dello spazio in cui viviamo perché sono questi le fondamenta dell’abitare, sono questi elementi che trasformano lo spazio indefinito in un luogo e ancor più in un luogo sentito come proprio, in un luogo che non è solo una dimensione spaziale ma anche temporale. Un altro antropologo, Franco La Cecla, mette alla base della costruzione di qualcosa che somigli ai luoghi di Augè una “mente locale” che è il presupposto per lo sviluppo della facoltà di abitare, cioè della capacità di percepire e di usare lo spazio per farlo diventare proprio, familiare. Per La Cecla la percezione di se stessi si definisce in rapporto al proprio ambiente quando questo può essere “manipolato” nel senso di oggetto di una continuo scambio, di una continua conversazione con i luoghi, operazione che crea un profondo senso di appartenenza ad esso.
L’uso della parola rende più facile esprimere tutta la serie di sensazioni e di emozioni, di sentimenti che legano il soggetto allo spazio in cui esso vive, in particolare quelli legati alla memoria e alle relazioni. Ma anche la fotografia con la sua capacità di mantenere un legame diretto con il soggetto fotografato, con la sua potenzialità espressiva legata alla sua natura ambigua, né indice né icona è uno strumento importante per la costruzione dell’identità, è lo è ancor più quando la fotografia è inserita in un progetto, in una dimensione espressiva complessa e articolata come è il raccontare.
massimocec aprile 2012