- Home
- Pisa
- San Giuliano Terme
- Città
- Le città visibili
- Massa
- Genova
- Carrara
- Lucca
- Livorno
- Qui Bologna, nel giardino di Monet
- Modena
- Venezia
- Cremona e i liutai
- Roma
- Mare
- Luoghi
- Luoghi e non luoghi
- Camporaghena o il borgo del silenzio
- Saluti e salute da San Casciano dei Bagni
- San Pellegrino in Alpe, la via Vandelli, le Apuane e l’Appennino
- Liguria
- Versilia
- Scanno
- Bolgheri
- Putzu Idu: vacanza sarda con gatto selvatico
- Il ghetto di Venezia e le isole
- Le Apuane
- La Maremma in bicicletta
- Clusone
- San Leo e la Romagna
- La Certosa di Pisa
- Montefoscoli
- Lerma e il Parco delle Capanne di Marcarolo
- Luoghi e fotografia
- Viaggiare
- Teatro e maschere
- Riti feste e cerimonie
- Dalle immagini alla scrittura
- Filosofia e fotografia
- E se la fotografia fosse arte?
- Las Meninas
- Artista o artigiano
- Pittura e fotografia, continuità o frattura?
- Carlo Delli: Creazioni
- Carlo Delli e la fotografia di paesaggio
- Ho un mio stile personale?
- Una fotografia bella o la natura del bello nella fotografia
- Fotografia surrealistica tra senso di realtà e senso del possibile: Musil
- Ma allora, e il Neorealismo?
- Cartoline e paesaggi
- Nostalgia, inquietudine e fotografia
- Fotografia immagine memoria e storia
- La storia attraverso le immagini: ricordo di Chiara Frugoni
- La storia attraverso le immagini: Trionfo della morte e Francesco d’Assisi
- Foto storiche San Giuliano Terme
- Al liceo: foto di classe
- San Michele
- Tre fotografie
- Il ghetto di Venezia e le isole
- Alcune fotografie di mia madre e una di mio padre
- La fotografia nella narrativa di Tabucchi
- Pittura, vita quotidiana e street photography
- Il significato in fotografia, un aiuto da Wittgenstein
- Donna nella fotografia: The Family of Woman
- Chiacchiere in libertà
- Un po’ di tutto
- Ospiti
- Ospiti graditi
- Fotografi amici
- Bruno Ferraro
- Antonio Tabucchi e l’equinozio
- To Ukraine with love
- Vela o non vela?
- Antonio Tabucchi in diretta
- L’emù di Ceserani
- Dunedin: il volo dell’albatro
- La mia ammirazione per Jacinda
- Per Pisa
- L’aquilone di Remo Bodei
- Alla griglia e al Supercampiello
- Takapuna Beach
- Vecchiano-Pisa Luoghi e incontri: anni Novanta
- La Coppa America e la baracca del poeta
- Luna Rossa Ineos 7a1
- Le balene di Antonio Tabucchi
- Chi siamo
- Curatori
- Odellac: autobiografia di un professore sangiulianese
- Massimocec
- Commiati
- Amici
- Commiati sangiulianesi
- Gilberto Vento era mio cugino
- Aristide Moretti
- Enzo Matteoni
- Dagoberto Fontanelli
- Vero Pellegrini
- Milena Moriani
- Virgilio Guidi, Piero
- Michele Antognoli
- Marino Venturi
- Lara Venturi
- Ugo Bertini
- Spartaco Baldi
- Giulio Cerrai
- Raffaella Dell’Omodarme
- Luciano Lorenzi, il Topo
- Delia Garibaldi Magli
- Marzio Baldassari
- Sergio Pistelli
- Franco Frandi
- Strumenti
Careghé
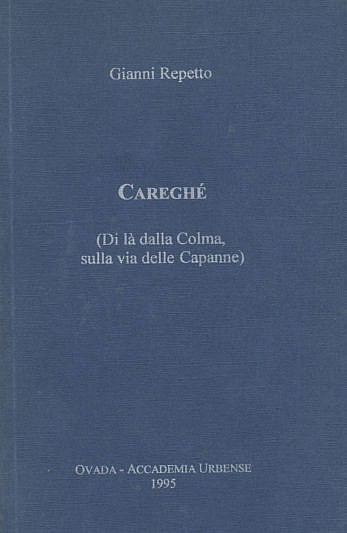 Il libro è la storia di un viaggio. Nel novembre del ’29 un contadino e suo figlio partono a piedi da Lerma, un piccolo paese del basso Piemonte alle propaggini dell’Appennino, per andare sui monti a fare delle sedie per i becelli, gli abitanti delle cascine della zona (il termine dialettale ‘bécélli’ è oggi assolutamente privo di significato in quanto il versante piemontese dell’Appennino compreso nei territori dei comuni di Lerma, Pagliolo, Casaleggio Borio, Momese e Bosio è pressoché spopolato). La vicenda si sviluppa in dieci capitoli, ciascuno dei quali coincide con una tappa in una cascina diversa ed evidenzia un aspetto particolare di quella realtà etnica e sociale definitivamente scomparsa negli anni del boom economico. 1 personaggi incarnano alcuni tipi caratteristici di quel mondo, così come mi sono apparsi nella tradizione orale della mia famiglia e negli scampoli di sopravvivenza che ho avuto modo di conoscere nella mia infanzia. Ho ancora ben presenti i carri degli ultimi becelli che scendevano a valle a portare la legna ai paesani oppure le coppie dì buoi montagnini con cui Miché d’Fanan o Bacicin della Cirimilla venivano a trainarci la bigoncia durante la vendemmia. Tutta la storia ha un presupposto reale (mio nonno e mio padre compirono effettivamente un ‘viaggio di lavoro’ sull’Appennino nell’inverno del ’29), sul quale ho cercato di innestare molti elementi del mio immaginario infantile, ricostruendo praticamente la dialettica che sarebbe intercorsa tra me e mio padre in una situazione analoga. In particolare ho insistito su un tema di fondo che ha occupato spesso la mia fantasia e che è stato condiviso da tanta altra letteratura fatta alle propaggini dell’Appennino: l’anelito verso il mare. E del resto questo sentimento, mediato a seconda del livello culturale, è una costante della mia gente. Genova per noi è il lavoro, il divertimento, il respiro sul mondo. E anche per Michele, il piccolo protagonista, lo scopo principale del viaggio è quello di raggiungere la cascina Sella da dove si può vedere il mare, l’oggetto del suo desiderio.
Il libro è la storia di un viaggio. Nel novembre del ’29 un contadino e suo figlio partono a piedi da Lerma, un piccolo paese del basso Piemonte alle propaggini dell’Appennino, per andare sui monti a fare delle sedie per i becelli, gli abitanti delle cascine della zona (il termine dialettale ‘bécélli’ è oggi assolutamente privo di significato in quanto il versante piemontese dell’Appennino compreso nei territori dei comuni di Lerma, Pagliolo, Casaleggio Borio, Momese e Bosio è pressoché spopolato). La vicenda si sviluppa in dieci capitoli, ciascuno dei quali coincide con una tappa in una cascina diversa ed evidenzia un aspetto particolare di quella realtà etnica e sociale definitivamente scomparsa negli anni del boom economico. 1 personaggi incarnano alcuni tipi caratteristici di quel mondo, così come mi sono apparsi nella tradizione orale della mia famiglia e negli scampoli di sopravvivenza che ho avuto modo di conoscere nella mia infanzia. Ho ancora ben presenti i carri degli ultimi becelli che scendevano a valle a portare la legna ai paesani oppure le coppie dì buoi montagnini con cui Miché d’Fanan o Bacicin della Cirimilla venivano a trainarci la bigoncia durante la vendemmia. Tutta la storia ha un presupposto reale (mio nonno e mio padre compirono effettivamente un ‘viaggio di lavoro’ sull’Appennino nell’inverno del ’29), sul quale ho cercato di innestare molti elementi del mio immaginario infantile, ricostruendo praticamente la dialettica che sarebbe intercorsa tra me e mio padre in una situazione analoga. In particolare ho insistito su un tema di fondo che ha occupato spesso la mia fantasia e che è stato condiviso da tanta altra letteratura fatta alle propaggini dell’Appennino: l’anelito verso il mare. E del resto questo sentimento, mediato a seconda del livello culturale, è una costante della mia gente. Genova per noi è il lavoro, il divertimento, il respiro sul mondo. E anche per Michele, il piccolo protagonista, lo scopo principale del viaggio è quello di raggiungere la cascina Sella da dove si può vedere il mare, l’oggetto del suo desiderio.
 Tutti gli avvenimenti sono filtrati attraverso l’occhio del ragazzo, il cui metro di giudizio oscilla tra il moralismo paterno e la caparbia spontaneità dell’infanzia che spesso si trovano in aperta contraddizione tra di loro. La condizione particolare del viaggio determina tra padre e figlio una sorta di confidenza conflittuale, che li porta a superare modernamente quella millenaria barriera gerarchica che condizionava tutti i rapporti nella famiglia contadina e impediva di fatto l’instaurarsi di un dialogo tra genitori e figli. E sia Paulin che Michele escono dal viaggio con delle certezze che finalmente coincidono. Entrambi infatti sono convinti che Michele un giorno se ne andrà per davvero. A questo punto interviene il fato. L’appendice «Una pietra al collo» lo introduce traumaticamente nella storia e risulta come una sorta di quadratura del cerchio nell’economia del libro. Lo stacco con tutto il resto è netto, perché la miseria, per quanto sia nera, non castra i nostri sogni, mentre la disgrazia, l’infermità e handicap fisico lasciano poco spazio alle illusioni. E’ vero oggi, figuriamoci nel 1929-30. La lotta allora sì che diventa di sopravvivenza. Anche questo è un elemento biografico reale della vita dì mio padre.
Tutti gli avvenimenti sono filtrati attraverso l’occhio del ragazzo, il cui metro di giudizio oscilla tra il moralismo paterno e la caparbia spontaneità dell’infanzia che spesso si trovano in aperta contraddizione tra di loro. La condizione particolare del viaggio determina tra padre e figlio una sorta di confidenza conflittuale, che li porta a superare modernamente quella millenaria barriera gerarchica che condizionava tutti i rapporti nella famiglia contadina e impediva di fatto l’instaurarsi di un dialogo tra genitori e figli. E sia Paulin che Michele escono dal viaggio con delle certezze che finalmente coincidono. Entrambi infatti sono convinti che Michele un giorno se ne andrà per davvero. A questo punto interviene il fato. L’appendice «Una pietra al collo» lo introduce traumaticamente nella storia e risulta come una sorta di quadratura del cerchio nell’economia del libro. Lo stacco con tutto il resto è netto, perché la miseria, per quanto sia nera, non castra i nostri sogni, mentre la disgrazia, l’infermità e handicap fisico lasciano poco spazio alle illusioni. E’ vero oggi, figuriamoci nel 1929-30. La lotta allora sì che diventa di sopravvivenza. Anche questo è un elemento biografico reale della vita dì mio padre.
Proprio di ritorno da quel viaggio, nella primavera successiva, perse una gamba, la destra. E se non si è poi gettato nel Piota con una pietra al collo, ha dovuto però lottare in modo sovrumano per riuscire ad essere considerato una persona normale.
Per quel che riguarda la forma di scrittura, innanzi tutto ho cercato di pensare tutta la vicenda in dialetto, così come ho spesso sentito ripetere certi fatti da mio padre e da altri miei parenti. Si poneva poi il problema di tradurla in un linguaggio italiano che non ne disperdesse le caratteristiche di immediatezza e di spontaneità. Nella parte narrativa ho dunque optato per una struttura del discorso poco complessa, nella quale prevalesse la paratassi, spesso anche inframmezzata da dei punti fermi. Ho inoltre fatto un uso frequente del “che” causale-dichiarativo, che è un elemento linguistico ossessivo della nostra parlata, ma irrinunciabile per tentare dì riprodurne il ritmo. Nei dialoghi invece ho tradotto letteralmente le battute pensate in dialetto, mantenendo la posizione del vari termini nella frase anche quando essa rischiava di stridere al confronto con la costruzione propria dell’italiano corrente.
Infine nel testo sono state inserite alcune forme di racconto nel racconto. In particolare nel li capitolo (la rievocazione autobiografica della guerra), nel V (il racconto della storia famigliare) e nel VI (il contafóre che narra la favola di Orsini, molto diffusa tra la mia gente, ma della quale non sono riuscito a trovare riscontro né nella raccolta di fiabe italiane di Calvino, né in quella di fiabe liguri di Boero e neppure in quella di fiabe piemontesi di Beccaria).
Gianni Repetto
a cura massimocec dicembre 2018


Leave a reply